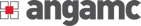|
Virgilio Guidi: Spazi di luce. Ogni qual volta che ci s'incontra con i dipinti di Virgilio Guidi, siano le celeberrime tele dei periodi ormai storici della prima metà del Novecento o siano quelle, altrettanto imprevedibili, realizzate negli ultimi fecondissimi anni, non cessano nuovamente di sorprendere la forza e la gittata della pittura, sia per la continua qualità d'ideazione sia per le novità specificatamente formali con cui egli ha saputo contrassegnare le pur svariate risoluzioni espressive. E di nuovo cresce allora il dubbio che, forse, non se ne sia stata esplorata del tutto la grandezza o, meglio, che le interpretazioni, quantunque autorevoli e gratificanti che sulla sua opera si sono in questi decenni largamente susseguite, non risultino sufficienti a fornirne un ritratto esauriente o almeno adeguato all'effettiva consistenza e portata delle tante esperienze creative dell'artista... E si avverte fintanto il bisogno di uscire persino da alcuni riferimenti divenuti magari obbligati, giacché storicamente ormai consolidati, e da valutazioni critiche, se non forse usurate, certamente invece circoscritte e limitative che hanno avuto, purtroppo, l'effetto di condizionarne l'intera ricerca a una tematica operativa univoca benché di cruciale radicalità, quale rimane del resto quella riferibile alla dominante prospettiva delia sua singolare concezione pittorica sulla luce. Da lui, in effetti, intesa, dunque ontologicamente, anzi quale fondamento di per sé ogni volta distintamente unificante delle stesse motivazioni estetiche ed esistenziali che stanno alla base del suo fare, ossia nel senso per l'appunto dei "pensare" e del "vedere" attraverso le sempre da lui rinnovate possibilità del linguaggio della pittura e dei suoi essenziali contenuti d'immagine. Più, d'altronde, si scoprono e si indagano i dipinti - che sono anche la più completa theoria dell'opera -maggiormente risalta l'originalità di quell’idea della luce quale orizzonte bensì intrascendibile e mai definibile una volta per sempre, ma di continuo da lui, infatti, presupposto ed incessantemente coniugato dunque nelle stesse molteplici forme dell’experiri, delle possibili nominazioni ed articolazioni concettuali e visive con cui l'essenza di quella "figura" - simbolo per eccellenza dell'assoluto - si è poi incarnata nell'immagine pittorica per aspirare a manifestarsi sub specie sui. Di conseguenza continuare a circoscrivere la ricerca di Guidi agli aspetti in ogni caso irriducibili di tale problematica, sebbene di per sé significativa della sua poetica, non esclude il rischio di vedere poi messo, ancora una volta, in secondo piano proprio quel principio unitario di colore, spazio, forma, come a dire quel trinomio strutturalmente costitutivo del suo pensiero luminologico con cui l’artista ha postulato o, meglio, ha sostanzialmente avvalorato il bisogno, per lui, delle tante versioni pittoriche sui medesimi soggetti, con lo scopo innanzi tutto di poter ognora sperimentare nuove proposizioni espressive all'interno però di un complesso ma non meno coerente sistema di relazioni formali e di sviluppi concettuali ed immaginativi. Ma se non si comprendono intanto le profonde ragioni spirituali e culturali di simile esigente processo speculativo si arriverà inevitabilmente a dover concludere che la pittura di Guidi sia stata impegnata a perseguire soltanto una qualche formulazione, più o meno astratta, attorno al problema della luce, trascurando o peggio ignorando viceversa le profonde ragioni delle sue inquietudini esistenziali e stilistiche e semmai considerandole al più - come finora è prevalentemente avvenuto-quale mero pretesto di aggiornamento linguistico e non come l'urgenza peraltro ineludibile, in lui, di ricercare e significare ogni volta altrimenti i contenuti originari di quella misteriosa entità che del resto agisce in maniera assoiutamente determinante sulla stessa esperienza della propria realtà pittorica. E' questa dimensione, insieme etica ed estetica, a condurre in sostanza l'artista alle folgoranti svolte che verranno a segnarne con intensità impareggiabile la di lui lunga traversata nella storia artistica del secolo in cui egli si pone - lo si riconosca o meno - quale uno del protagonista di primo piano. E non solo per le capitali opere degli anni Venti, dalla "Donna che si leva", del 21, alle due versioni de "Il dirigibile", del 22; dalla "Visita" del 23, al "Tram", del 24; dalla "Giudecca" del 27 al "Ritratto di Adriana", sempre dello stesso anno -memorabili incunaboli di un realismo magico di ancora classica, stupefacente bellezza formale - ma altresì per quelle inusitate elaborazioni rivolte a figurare una possibile fenomenologia deFautre". Dimostrando anzi di saper persino trascendere le stesse ipotesi psico-organistiche dell'informale, per liberare, piuttosto, l'energia della luce spaziale, epifania insieme dell’idea di un assoluto irraggiungibile e del divenire della sua riflessa forma empirica, alle quali è stupendamente approdato l’ultimo percorso espressivo dell’artista. In effetti, lo spazialismo luminologico di Guidi possiede una propria inconfondibile originalità e per di più progressivamente evolutosi dal raffronto con matrici storiche meno contingenti - nientemeno che da Piero della Francesca a Matisse - ma altrettanto capace in se dispiegare un processo di trasformazione radicale degli statuti rappresentativi dell'immagine, anzi i istituendo a tale proposito un sintetismo lessicale di estreme pronunce visive, oltre ogni condizionamento meramente linguistico o funzionalmente sfrumentativo. La pittura di Guidi riflette prodigiosamente questo percorso stilistico, superando il conflitto, ideologicamente pregiudiziale, fra figurativo ed astratto, arrivando essa a precorrere addirittura territori espressivi poi attraversati dalle correnti internazionali della Transavanguardia. Proprio tale parabola è apparsa a sconcertare quanti, critici o meno, sono abituati a registrare novità da codificare e, comunque, codificabili, ma restii invece a cogliere situazioni di così vasta portata prospettica. Le stagioni creative di Guidi, come quelle di Picasso, sono state tante e diverse, ognuna delle quali poteva ugualmente garantirgli meritamente una fama duratura, peraltro da lui acquisita sin dai suoi clamorosi esordi alle Biennali del 1922 e del '24, ma egli ha preferito ricercare, con pari rigore e forza innovativa, qualcosa che non è soltanto il senso dell'arte, qualcosa che non è solo coscienza della storia vissuta, ma che investe il mistero dell'essere e la sua dimensione nel mondo. Nel girone pittorico dei cieli che rappresentano le immagini da lui dipinte, nel decennio degli anni Settanta, la mostra odierna presenta taluni esempi straordinari, alcune tipologie sul motivo degli "Occhi nello spazio" e delle "Grandi teste", potenti figurazioni da; tratti essenziali, da indicibili trasparenze luminose, puri spazi di luce - per riprendere il titolo di una sua silloge di poesie - abitati da sguardi che ci scrutano da dentro e fuori di noi; "tumulti" di vorticosi abissi, di "segni" di drammatici conflitti; di ascesi interiori liricamente evocate, di splendori effusivi, sconfinati e sconfinanti in una realtàdavvero "autre". |